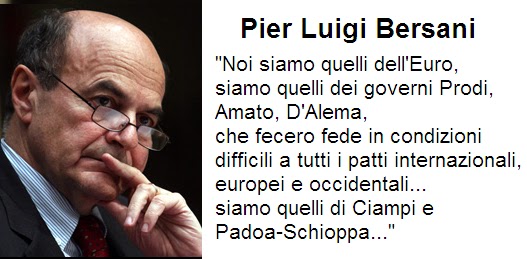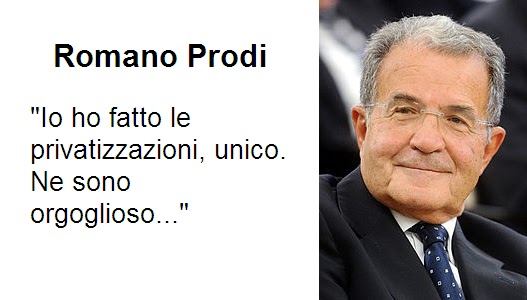Occhio ai falsi amici in lingua inglese. I documenti europei destinati alla scuola ne sono pieni. Ne faremo un dizionarietto a puntate, cominciando dalle amicizie più pericolose:
Governance
Governance
La governance tende ad essere scambiata per il governo, ma si tratta ovviamente di un penoso equivoco. Il governo, infatti, ricorda l'indirizzo politico di uno stato, l'esecutivo nazionale, le elezioni, gli accordi tra partiti, la cosiddetta "democrazia", un termine poco scientifico, che si presta a fraintendimenti. Governo, insomma, è un concetto grossolano, una rozza semplificazione racchiusa in un'equivoca parola. Chi la usa con troppa fiducia e ingenuità, in italiano, è portato a distinguerla frettolosamente da altri termini affini ma subordinati: dall'amministrazione, che si addice a realtà più piccole, che rischiano di essere sottoposte allo stato (e quindi all'azione del governo); dalla direzione, che si riferisce alla guida di organizzazioni e società; dalla gestione, tipica di uffici che agiscono in applicazione di indirizzi decisi a un livello superiore. Troppe cavillose distinzioni, troppe anacronistiche gerarchie, che finiscono col dare un'eccessiva importanza al governo, con la scusa, appunto, della cosiddetta "democrazia", idea certamente rispettabile ma sempre sul punto di scadere nel teatrino della politica, nella demagogia o nel populismo. L'italiano, poi, è una lingua che molto si presta a queste elucubrazioni, ed è pertanto particolarmente esposta a possibili degenerazioni.
Meglio allora passare al più sintetico e pragmatico inglese e usare governance per unificare l'intera problematica. La governance non è proprio un governo, ma è più che una mera amministrazione, e può indicare un'efficace direzione, nonché i solidi principi di una buona gestione. E quando vi è una buona gestione diffusa e un'efficace direzione viene anche ridimensionata l'esigenza di avere un forte governo, che finalmente, senza ergersi a protagonista, potrà limitarsi ad arbitrare, prevenendo così il rischio di eventuali errori. Ecco la governance, che fa riferimento a un sistema di pesi e contrappesi, tipico delle società aperte, plurali, dinamiche e competitive. Nella governance chi governa non è mai solo, mai abbandonato a se stesso, e sembra in realtà a sua volta amministrato dentro una cornice più ampia, sensibile alle esigenze degli attori economici e sociali (ad esempio le imprese, le aziende e le banche, o, ancor meglio, le banche e le banche). E d'altra parte, per contrappeso, anche chi amministra chi governa, grazie alla comune governance, a ben guardare, appare "ex ante" eterodiretto da solidi principi di buona gestione, che garantiscono una mutua e sistemica cooperazione (le imprese per le banche, le banche per le imprese, ma anche e soprattutto, a garanzia dei depositi e dunque dell'interesse generale, le banche per le banche).
Tale complesso intreccio istituzionale, economico e giuridico, costituisce appunto la governance, e con questa il metodo autenticamente democratico, un metodo che pone le libere società al riparo dai rischi del populismo e della demagogia, sempre presenti nei processi elettorali, in particolare nei momenti di crisi. Infatti, quando gli elettori scelgono nel senso dell'interesse collettivo, della competenza e della libertà (e dunque per le imprese libere e per le libere imprese, tipicamente le banche), grazie alla governance prevale la buona gestione nel riconoscimento dei meriti dei meritevoli. Qualora, però, in spregio allo spirito democratico e alla scienza economica, dovessero imporsi i populismi, con il ritorno a governi di non competenti, di non meritevoli e di non tolleranti, sarà allora la governance a intervenire e a rimediare, rimettendo in equilibrio il sistema con l'aiuto dei mercati, del ranking, dello spread e degli altri indicatori scientifici, attraverso interventi conformi alla reale realtà delle cose e all'effettiva fattualità dei fatti.
In campo scolastico, dopo anni di astratto egualitarismo e di mancato riconoscimento dei meriti dei meritevoli, si è sentita finalmente l'esigenza di una vera governance, capace di introdurre linee di competitività e di scientificità nel settore, dotando anche le scuole di adeguati strumenti, di un ranking e di uno spread, secondo le ricerche OCSE e il metodo sperimentale Invalsi. Tale policy, rivolta all'innovazione e al miglioramento continuo, sta però faticando a imporsi, attraverso un tormentato processo, che ha trovato nella legge 107/2015 (Buona scuola) la sua espressione più completa e ambiziosa, ma per il momento ancora disattesa. Un ritardo che potrebbe costare caro al nostro paese...
Policy
Soggetti non adeguatamente formati potrebbero tradurre la policy con il termine italiano "politica", un concetto in verità troppo generico e carico di ambiguità. Va subito chiarito, invece, che la policy rappresenta una dimensione ben più concreta e fondata metodologicamente.
La policy, precisamente, è infatti quel che rimane della politica dopo che si è adottata la governance. Dunque una politica purificata, depurata dai suoi errori grazie alla governance. Più niente che possa ricondurre alle ideologie, ai settarismi, ai nazionalismi, alle chiusure e ai partitismi del passato. La policy, al contrario, è aperta al futuro, alle novità, alle tecnologie e agli attori del cambiamento, ai produttori, ai consumatori, alle imprese socialmente responsabili e trainanti, dalle company alle authority, dai gruppi finanziari agli istituti di credito, dalle banche alle banche e alle banche.
Stakeholder
Gli stakeholder sono i principali interlocutori nella costruzione della policy all'interno di un corretto sistema di governance, e stanno precisamente all'origine del progetto (quali artefici della domanda) e alla sua conclusione (quali utilizzatori del prodotto). Nella scuola riformata, nel senso della costruzione di un curricolo per competenze €uropee, dovrebbero contribuire in misura decisiva sia al momento dell'input che a quello dell'output.
Purtroppo il termine, talvolta rozzamente tradotto con "portatori di interesse", nel contesto italiano, spesso incline a disconoscere la portata sociale degli interessi economici e a comprimere il mercato, non è stato per il momento ben compreso e metabolizzato. A causa di questo ritardo culturale, non operano ancora, nel nostro sistema scolastico, veri e propri stakeholder, come si afferma con crudezza qui.
Competence
La competence è quella forma di competitività che trasforma la risorsa studente (orientata al profitto scolastico) in risorsa umana effettiva (impegnata in compiti di realtà, cioè diretti al profitto economico).
La competitività della competence, in quanto indirizzata allo sviluppo e all'incremento del PIL, rappresenta anche l'unico modo per ridurre il debito e per rafforzare, di conseguenza, i diritti sociali, venendo così incontro ai bisogni collettivi.
In una società "basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo", vedi strategia di Lisbona, non ci sono alternative. Non c'è altra strada per ridurre povertà e disoccupazione, o meglio per contenerle entro limiti fisiologici e strutturali.
Competency
Secondo alcuni la competency è un sinonimo della competence. Secondo altri la competence si riferisce alle risorse umane in generale (human resources), mentre la competency riguarda setting più specificamente scolastici (competency-based learning).
Al pari della competence, comunque, anche la competency, operando nel senso del riconoscimento dei diritty socialy, riduce povery e disoccupaty, già ridotti in precedenza in myseriah dall'austerity della policy della governance. Ciò avviene, però, non attraverso la creazione di posti di lavoro da parte dello stato (ohibò), azione proibita perché non conforme alla governance, ma incentivando l'occupability, di cui vi parleremo un'altra volta...
Nel frattempo, credeteci, e se volete di conseguenza conseguire nuovi credici formativi, abbonatevi al dizionario dei luoghi ingannevoli, inglese - italiano, italian - english, e occhio ai falsi amici in inglese compatto.
Tale complesso intreccio istituzionale, economico e giuridico, costituisce appunto la governance, e con questa il metodo autenticamente democratico, un metodo che pone le libere società al riparo dai rischi del populismo e della demagogia, sempre presenti nei processi elettorali, in particolare nei momenti di crisi. Infatti, quando gli elettori scelgono nel senso dell'interesse collettivo, della competenza e della libertà (e dunque per le imprese libere e per le libere imprese, tipicamente le banche), grazie alla governance prevale la buona gestione nel riconoscimento dei meriti dei meritevoli. Qualora, però, in spregio allo spirito democratico e alla scienza economica, dovessero imporsi i populismi, con il ritorno a governi di non competenti, di non meritevoli e di non tolleranti, sarà allora la governance a intervenire e a rimediare, rimettendo in equilibrio il sistema con l'aiuto dei mercati, del ranking, dello spread e degli altri indicatori scientifici, attraverso interventi conformi alla reale realtà delle cose e all'effettiva fattualità dei fatti.
In campo scolastico, dopo anni di astratto egualitarismo e di mancato riconoscimento dei meriti dei meritevoli, si è sentita finalmente l'esigenza di una vera governance, capace di introdurre linee di competitività e di scientificità nel settore, dotando anche le scuole di adeguati strumenti, di un ranking e di uno spread, secondo le ricerche OCSE e il metodo sperimentale Invalsi. Tale policy, rivolta all'innovazione e al miglioramento continuo, sta però faticando a imporsi, attraverso un tormentato processo, che ha trovato nella legge 107/2015 (Buona scuola) la sua espressione più completa e ambiziosa, ma per il momento ancora disattesa. Un ritardo che potrebbe costare caro al nostro paese...
Policy
Soggetti non adeguatamente formati potrebbero tradurre la policy con il termine italiano "politica", un concetto in verità troppo generico e carico di ambiguità. Va subito chiarito, invece, che la policy rappresenta una dimensione ben più concreta e fondata metodologicamente.
La policy, precisamente, è infatti quel che rimane della politica dopo che si è adottata la governance. Dunque una politica purificata, depurata dai suoi errori grazie alla governance. Più niente che possa ricondurre alle ideologie, ai settarismi, ai nazionalismi, alle chiusure e ai partitismi del passato. La policy, al contrario, è aperta al futuro, alle novità, alle tecnologie e agli attori del cambiamento, ai produttori, ai consumatori, alle imprese socialmente responsabili e trainanti, dalle company alle authority, dai gruppi finanziari agli istituti di credito, dalle banche alle banche e alle banche.
Stakeholder
Gli stakeholder sono i principali interlocutori nella costruzione della policy all'interno di un corretto sistema di governance, e stanno precisamente all'origine del progetto (quali artefici della domanda) e alla sua conclusione (quali utilizzatori del prodotto). Nella scuola riformata, nel senso della costruzione di un curricolo per competenze €uropee, dovrebbero contribuire in misura decisiva sia al momento dell'input che a quello dell'output.
Purtroppo il termine, talvolta rozzamente tradotto con "portatori di interesse", nel contesto italiano, spesso incline a disconoscere la portata sociale degli interessi economici e a comprimere il mercato, non è stato per il momento ben compreso e metabolizzato. A causa di questo ritardo culturale, non operano ancora, nel nostro sistema scolastico, veri e propri stakeholder, come si afferma con crudezza qui.
Competence
La competence è quella forma di competitività che trasforma la risorsa studente (orientata al profitto scolastico) in risorsa umana effettiva (impegnata in compiti di realtà, cioè diretti al profitto economico).
La competitività della competence, in quanto indirizzata allo sviluppo e all'incremento del PIL, rappresenta anche l'unico modo per ridurre il debito e per rafforzare, di conseguenza, i diritti sociali, venendo così incontro ai bisogni collettivi.
In una società "basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo", vedi strategia di Lisbona, non ci sono alternative. Non c'è altra strada per ridurre povertà e disoccupazione, o meglio per contenerle entro limiti fisiologici e strutturali.
Competency
Secondo alcuni la competency è un sinonimo della competence. Secondo altri la competence si riferisce alle risorse umane in generale (human resources), mentre la competency riguarda setting più specificamente scolastici (competency-based learning).
Al pari della competence, comunque, anche la competency, operando nel senso del riconoscimento dei diritty socialy, riduce povery e disoccupaty, già ridotti in precedenza in myseriah dall'austerity della policy della governance. Ciò avviene, però, non attraverso la creazione di posti di lavoro da parte dello stato (ohibò), azione proibita perché non conforme alla governance, ma incentivando l'occupability, di cui vi parleremo un'altra volta...
Nel frattempo, credeteci, e se volete di conseguenza conseguire nuovi credici formativi, abbonatevi al dizionario dei luoghi ingannevoli, inglese - italiano, italian - english, e occhio ai falsi amici in inglese compatto.